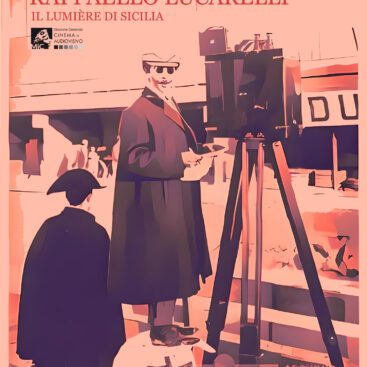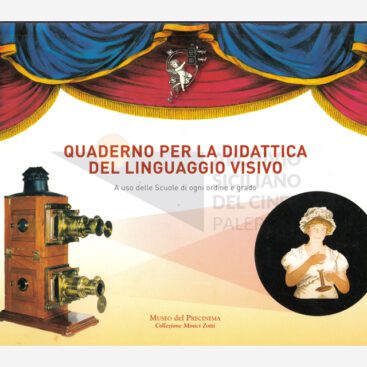L'Eldorado dei poveri: i viaggi dell'icononauta
Gian Piero Brunetta
L'apparecchio brevettato dai fratelli Lumière nel febbraio 1895 batte allo sprint invenzioni analoghe di un folto gruppo di scienziati e inventori francesi, tedeschi, inglesi, americani e italiani e produce, in seguito, una serie ininterrotta di scosse sia all'edificio tecnologico che a quello linguistico. Prima del cinematografo ci imbattiamo in nomi come coreutoscopio, lampascopio, lucifono: a partire dal 1896 la corsa ai brevetti produce neologismi a catena. Tra le oltre duecento invenzioni francesi possiamo trovare per esempio il cinegrafo, il fototeatrografo, il fotopoligrafo, il cinegrafoscopio, il fototropo, lo zografo, il pantomimografo, il cromovivigrafo e così via.
Ma già ben prima dei Lumière le macchine della visione, dalle camere oscure ai cosmorami, ai fenachistoscopi, agli aletoscopi fino ai praxinoscopi di Emile Reynaud e ai kinetoscopi di Edison, avevano aperto la possibilità di diffondere a pioggia su popolazioni distanti e differenti gli stessi saperi e le stesse emozioni e, come vere e proprie metafore dell'occhio, erano riuscite a fissare e accogliere al loro interno le immagini del mondo e a consentire di rimisurarlo, visitarlo, riconoscerlo e raccontarlo attraverso un discorso visivo e non solo verbale.
C'è un verso della Divina Commedia che riprende una frase della profezia di Tiresia dell'Odissea in cui si dice "dei remi facemmo ali al folle volo" che, come una scintilla, ha innescato le prime associazioni della presente ricerca sul viaggio o sul "volo dell'Icononauta", del viaggiatore nelle immagini, sui luoghi da lui visitati o abitati, sulle sue reazioni emotive, sugli strumenti utilizzati di volta in volta, sulle mappe reali e su quelle dell'immaginario e sugli itinerari e sulle rotte seguite nel corso dei secoli.
L'Icononauta è, a pieno titolo, un Ulisside: la sua curiosità e la sua disponibilità alla fascinazione e a esplorare dimensioni altre, le sue deambulazioni emotive lungo i territori del proibito per incontrare fantasmi e dèmoni, il suo coraggio e la sua capacità di varcare con Robertson il regno dell'Ade sono degne d'attenzione quanto quelle dei viaggiatori del Settecento, anche se non hanno lasciato analoghe tracce visibili. Mentre ai tradizionali viaggiatori è concesso passare da un luogo all'altro senza vedere (e questo ovviamente è un fenomeno che si accentua tanto più ci si avvicina ai giorni nostri), l'Icononauta, come Ulisse è polytropos: tanto più sa guardare tanto più il suo viaggio si allunga. Ma questo viaggio è pieno di paure e le immagini delle lanterne magiche il più delle volte lo attirano in territori sconosciuti e infidi. Nel ripetersi periodico dell'avventura visiva l'Icononauta viene ogni volta galvanizzato se non letteralmente fulminato dall'immagine e al tempo stesso sente che quelle immagini a cui sta assistendo richiamano i fantasmi e i ricordi di esperienze visive precedenti che stanno nel suo teatro interiore. (...)